La fine di un impero
- logosgiornale
- 6 set 2021
- Tempo di lettura: 6 min

ERA IL 22 APRILE 1519 quando una piccola flotta di avidi avventurieri spagnuoli partiti da Cuba con undici caravelle sbarcò sulle coste dello Yucatán, pronti ad esplorare l’entroterra del Messico verso i dominî degli Aztechi. Erano appena più di cinquecento uomini e sedici cavalli. La spedizione, fortemente voluta dal governatore di Cuba Diego Velásquez de Cuéllar, era guidata da un già ribelle Hernán Cortés, conquistador al servizio della Corona di Spagna, ma sollevato dall’incarico di segretario del governatore appena prima di partire con l’accusa di tradimento.
Nonostante ciò il 18 aprile Cortés partì senza farsi troppi scrupoli e una volta sbarcato in territorio maya si pronunciò chiaramente, affermando «Siamo venuti per servire Dio, il Re e anche per diventare ricchi.»[1] Fondò subito la città di Vera Cruz, base per le future spedizioni, per ribadire il carattere provvidenzialistico della missione e ostentare la sua cattolicissima devozione. Fu abile stratega sia nel raccogliere informazioni sul territorio sia nell’avvalersi dell’aiuto di popolazioni ostili agli Aztechi, quali i Toltechi, che, facendo da interpreti, gli permisero di affrontare le non trascurabili barriere linguistiche. Scoperti i dissensi tra i popoli sottomessi vi strinse presto alleanze; da alcune popolazioni con le quali Cortés venne in contatto l’impero azteco esigeva pesanti tributi in termini di tassazioni e di vittime sacrificali. Il conquistador ebbe buon gioco nel proporsi come riparatore di torti in missione per conto di Carlo V e della Fede cattolica.
Accolti favorevolmente dagli indigeni anche a causa di segni interpretati come premonitori e agli stessi miti ancestrali della loro antica dottrina religiosa, gli spagnuoli, che erano giunti con la Bibbia in una mano e con moschetti e archibugi nell’altra, furono venerati come emissari di Quetzalcoatl, una delle divinità principali del pantheon azteco, tanto che lo stesso tlatoani (termine con il quale si può intendere la parola “imperatore” in lingua precolombiana) MontezumaII li accolse con ambascerie di doni. Ma l’obiettivo della loro venuta fu presto chiaro. Quando giunsero a Tenochtitlán, capitale azteca, Hernán Cortés era già circondato dalla fama di imbattibilità, oltre che da un esercito di quasi tremila indios passati alla sua causa. Non passò molto che gli spagnuoli arrestarono il sovrano Montezuma, costringendolo a sottomettersi al re di Spagna. Cortés assunse il controllo politico e rimpiazzò con la forza il cattolicesimo al loro culto politeista. La crudeltà e la slealtà degli occupanti provocò ben presto delle rivolte; ma, nonostante l’abilità e il coraggio dei soldati aztechi, le sedizioni si conclusero con la morte di Montezuma e, dopo un lungo assedio, con la caduta di Tenochtitlán nel 1521. Fu grazie a questi successi che Cortés ricevette l’onorificenza di governatore e capitano generale dei nuovi territori, radunati sotto il nome di Vicereame di Nuova Spagna.
I motivi per cui gli Spagnuoli ebbero tanto successo sugli eserciti precolombiani furono non tanto l’impiego di armi da fuoco, sconosciute agli indigeni, e di cavalli, quanto lo sfruttamento della preesistente debolezza dell’impero azteco, afflitto da divisioni intestine e dal suo primitivo sistema di dominio sulle popolazioni sottomesse e la favorevole circostanza che vide i nativi fragili di fronte alle numerose malattie infettive, quali vaiolo, tifo, scarlattina, che gli Spagnuoli gentilmente importarono e con le quali loro non erano mai venuti in contatto. Inoltre ben poco fu fatto inizialmente per contrastare l’avanzata degli Europei, poiché si ritenne che la loro comparsa fosse l’avveramento di una antica profezia secondo la quale una divinità avrebbe distrutto il loro impero sulla regione, considerando l’invasione come qualcosa di fatalmente inevitabile.
GLI AZTECHI E I MAYA
Il consolidamento di un dominio azteco (o mexica) di dimensioni ragguardevoli si data al periodo compreso fra il regno di Montezuma I, alla metà del Quattrocento, e di Montezuma II, agli inizi del Cinquecento. In origine nomadi e cacciatori, essi si trasferirono verso la fine del XII secolo, assieme ad altri popoli dello stesso gruppo etnico, sugli altopiani centrali del Messico. Durante gli ultimi anni di regno di Montezuma I (1440-1469), fra conquiste e stipulazioni di accordi, si venne costituendo un sistema politico che dominava un territorio quattro volte più vasto che in precedenza.
Ma la più antica delle civiltà precolombiane è senza dubbio quella dei Maya, ormai in declino all’arrivo degli Spagnuoli. Insediatisi nelle regioni del Guatemala, dello Yucatán e dell’Honduras già dalla metà del II millennio a.C., il loro periodo di massimo splendore fu tra il III e il IX secolo d.C. Era stato allora che erano sorte centinaia di città-stato, centri di potere che godevano di piena autonomia e che avevano il loro fulcro negli edifici di culto. I Maya avevano sviluppato un sistema di scrittura geroglifica molto complessa[2], una scienza astronomica estremamente esatta, che era alla base del loro calendario solare di 365 giorni, e un’aritmetica assai evoluta, che faceva uso dello zero.
LA VENEZIA DEGLI AZTECHI
Chi visita oggi Città del Messico, di Tenochtitlán può vedere solo i resti del Templo Mayor[3] e alcuni preziosi reperti nel Museo Nacional. Sopra all’antica capitale degli Aztechi, infatti, c’è oggi il centro di una megalopoli di 8 milioni di abitanti.
A fondare Tenochtitlán nel 1325 fu il leggendario capo azteco Tenoch. Il luogo non fu scelto a caso, visto che fu indicato dalla visione di un’aquila intenta a mangiare un serpente in cima a un cactus (immagine che in seguito divenne l’emblema del Messico): la città sorgeva su un’isola al centro del lago Texcoco. Lì nel giro di breve tempo arrivarono almeno 200mila persone, molte più di quelle che popolavano una capitale europea nella stessa epoca. Tenochtitlán divenne un modello di efficienza: un acquedotto funzionale, una rete capillare di strade e canali (ogni zona si raggiungeva a piedi o in canoa) e mercati. Al centro della città – il cui piano urbanistico era controllato da un funzionario specializzato – c’erano edifici pubblici e templi. Su quelle rovine, dopo il 1521, gli spagnoli costruirono la loro capitale coloniale.
RELIGIONE E SOCIETÀ PRESSO GLI AZTECHI
Gli Aztechi avevano una religione basata sull’idea di un ordine cosmico continuamente esposto al rischio di essere annientato da cicliche catastrofi naturali o per la collera dei loro dei. Il pantheon azteco era infatti costituito da divinità spesso ostili nei confronti dell’uomo, identificate perlopiù con gli elementi della natura o con idee astratte come la guerra. Per garantirsi la benevolenza divina, gli Aztechi ricorrevano a sacrifici umani, il cui sangue sarebbe servito a preservare la forza vitale dei vari dei. Le vittime di questi sacrifici, celebrati in templi costituiti da grandi piramidi a gradoni, erano per lo più prigionieri catturati nelle tante guerre condotte contro le altre popolazioni indigene.
Oltre che dalla classe sacerdotale la società azteca era dominata da un ceto di nobili che godeva del possesso privato delle terre; i liberi non nobili godevano solamente di una specie di usufrutto sulle terre che lavoravano. L’ultimo gradino della piramide sociale era occupato ovviamente dagli schiavi.
I SACRIFICI DEI PRECOLOMBIANI
I sacrifici umani (oltre a quelli di varie specie di animali) erano un aspetto importante della religione delle popolazioni precolombiane del Mesoamerica. Antiche cronache spagnuole sostengono che ogni anno più di 20 mila persone venissero immolate agli dei. Si trattava per lo più di prigionieri di guerra immolati al dio Huitzilopochtli (dio della guerra appunto), anche se pare che, in mancanza di altro, gli Aztechi chiedessero un tributo di vittime alle popolazioni sottomesse, per nutrire con il loro sangue le divinità o placare la loro ira in caso di carestia e siccità.
Nella “Historia de los indios e de la Nueva España” (1536) frate Toribio de Benavente riferì che in Messico, durante le feste in onore del dio Huitzilopochtli il sacerdote estraeva il cuore della vittima e lo presentava al sole. A volte lo mangiava o lo seppelliva prima di gettare il resto del corpo dalle scale del tempio. Ma se si trattava di un prigioniero di guerra, chi lo aveva catturato banchettava insieme agli amici con le sue carni.
Il sangue, considerato linfa vitale, era l’offerta più ambita: per questo Olmechi e Maya praticavano l’autosacrificio. Abbiamo testimonianza di ciò grazie a molti bassorilievi che descrivono il rituale: i sovrani e le loro spose, ma anche sacerdoti e sciamani, si foravano la lingua o gli organi sessuali con punte di ossidiana o spine di agave. Secondo le credenze il sangue, che usciva copioso, nutriva la terra e rendeva abbondante il raccolto.
[1]Bernal Diaz del Castillo, cronista della spedizione in “Historia veneranda de la conquista de la Nueva España”, pubblicato postumo a Madrid nel 1532. [2] Il russo Jurij Knorosov, che pur vivendo ai margini della comunità scientifica (lavorò nell’Urss di Stalin e Breznev), comprese che i segni (detti glifi) che i Maya utilizzavano hanno un valore fonetico e che la scrittura maya è logo-sillabica, fatta di segni che possono rappresentare sia parole di senso compiuto, sia sillabe. Oggi sappiamo che i testi del periodo classico (300-900 d.C.) sono scritti in Ch’olti classico, una lingua oggi estinta e che probabilmente si era affermata come lingua franca ufficiale, come in Europa il latino in età medievale, o il greco in epoca ellenistica all’interno del bacino del Mediterraneo orientale. La prova più evidente che si tratti di una scrittura è data non tanto dalle decifrazioni dei testi, quanto dal fatto dal fatto che con i glifi maya si può leggere e scrivere qualsiasi cosa. [3] Il Templo Mayor era dedicato a Tlaloc, dio della pioggia, e a Huitzilopochtli, divinità della guerra. Qui, durante la conquista spagnola, fu trucidata la corte del sovrano Montezuma II. La base del tempio, alto 60 metri, a gradoni e probabilmente dipinto, misurava 250mila m2.
Paolo Di Carlo



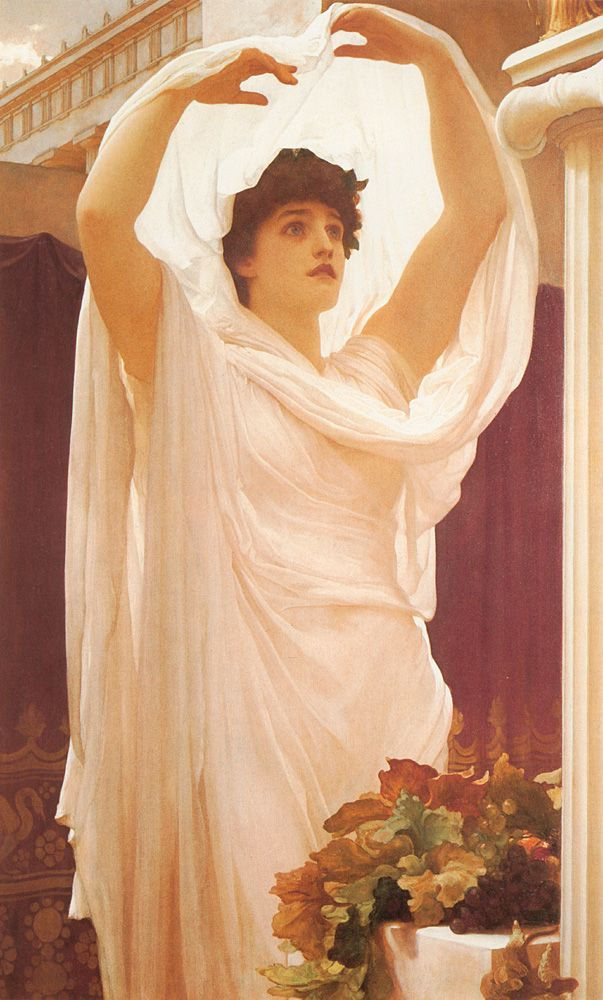

Commenti